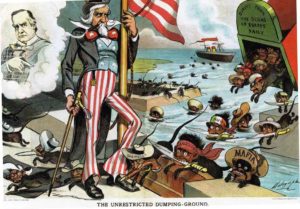(Ripensavo a un testo per questo primo maggio e per questo lavoro piuttosto deteriorato e mi è venuto in mente un capitolo del mio romanzo Santamamma. Ora, non è mai bello autocitare un romanzo, suona sempre come mossa promozionale, eppure è una scena che contiene molte delle cose che ho vissuto io che sono di quella generazione a cavallo tra il “lavoro” come lo intendevano i nostri genitori e poi il “lavoro” come sarebbe diventato. Eccolo qui)
«Carlo Gatti»
«Sì, buongiorno. Eccomi.»
«Titolo di studio?»
«Maturità classica.»
«E basta?»
«Già, sì.»
«Strano, una maturità classica senza università…»
«Ho preferito cominciare a lavorare.»
«Sì. Ma non ha cominciato a lavorare visto che è qui per il colloquio.»
«Ho fatto il benzinaio.»
«Con la maturità classica. Un po’ pochino, eh. Chissà come saranno stati fieri i suoi genitori.»
«Lavoro estivo. Una cosetta così.»
«Ma qui c’è scritto settembre aprile.»
«Intendevo estivo nell’interpretazione. Anche se d’inverno.»
«Ah, nell’interpretazione, pensa te. Speriamo che non interpreti anche di fare finta di lavorare, ahinoi.»
L’ufficio aveva piante finte in tutti gli angoli. Smorte comunque. Almeno una spolverata, pensavo, almeno quella ci vorrebbe. Lui rigirava una penna. Lo insegnano a tutti gli ingiacchettati: tenere qualcosa tra le mani evita la fatica di pensare dove metterle. Trucchetto curioso per chi dovrebbe ribaltare l’economia del mondo, ma tant’è. I colloqui di lavoro hanno tutti un filo comune: la recitazione da parte dell’esaminato di un bisogno ma non troppo, di un entusiasmo ma non troppo, di competenze ma non troppo, di umiltà ma non troppo, di troppa buona educazione e una combinazione d’abiti che non vedi l’ora di dismettere. L’esaminatore, invece, sfoggia l’abilità di esaminare ma non troppo, annusa che tu sia brillante ma che non possa fare ombra, gioca al caporale e tu la truppa e poi diventa servo se entra il capo. Al decimo colloquio di lavoro potresti farne la regia in un teatro da mille posti, disegnarne la radiografia. Che messinscena.
«Suona. Anche.»
«Suonavo. Ho studiato pianoforte fin da piccolo. E violoncello.»
«La mia figlia più piccola va a danza. Le maestre dicono che sia portata. Vedremo un po’. Quindi ha suonato alla Scala?»
«Alla Scala c’è una stagione sinfonica. Non concerti solisti.»
«Ho capito, ho capito. Suonava così. Per passione…»
«Ho studiato. Frequentavo anche il conservatorio.»
«Ah, è diplomato! Allora un giorno la invito a vedere mia figlia ballare così mi dice.»
«Non mi sono diplomato. Mi sono fermato al nono anno.»
«Gatti, Gatti… non è riuscito a finirne una…»
«Ho avuto un lutto in famiglia.»
«Oh, mi spiace.»
Almeno un limite di potabilità, me lo ero imposto. Almeno non farsi sbavare addosso. E il lutto è un jolly: funziona a scuola per l’interrogazione e funziona anche qui. Del resto sono tutti maestrini, questi qui.
«Le spiego. Lei sa di cosa ci occupiamo?»
«Ho preso alcune informazioni. Consulenza aziendale specializzata in logistica, mobilità e ottimizzazione.»
«Ha sfogliato il depliant. Almeno quello l’ha finito.»
«Mi informo sempre. Amo sapere con chi sto andando a parlare.»
«Va bene Gatti, adesso non esageriamo. Quello è il mio lavoro. Comunque: esistiamo dal 1949 e il fondatore era un piccolo padroncino che si occupava di consegne e spedizioni nella zona fino poi a coprire tutto il territorio nazionale. Quando l’azienda è passata di mano al figlio, il signor Monti che poi è quello che la pagherebbe se io decido che lei può andare bene, abbiamo deciso di internazionalizzare l’impresa e oggi siamo tra i leader in Europa nella consulenza per le più importanti aziende logistiche. Trattiamo bancali e container che partono dall’Islanda e viaggiano fino alla Nuova Zelanda. Spedizioni che fanno il giro del mondo. Mi segue?»
È forte questa cosa degli incravattati che ripetono manfrine sulla storia dell’azienda com’è scritta sui volantini. È la recita di natale che si ripropone nella versione adulta, solo che qui a noi tocca fare i parenti commossi.
«Noi ci occupiamo che la spedizione avvenga con tutti i crismi: velocità, cortesia, qualità e produttività, soprattutto. Produttività. Abbiamo due divisioni: slancio e controllo. La figura che cerchiamo è per il reparto di slancio.»
«Sì. Di slancio. Che sarebbe?»
«Molto semplice. Il cliente x dice che deve spedire il bancale y da Roma a Berlino. Lei ha i numeri telefonici dei camionisti che collaborano con noi e il nostro sistema le fornisce un’indicazione di prezzo che noi chiamiamo cuneo. Il suo lavoro è di trovare velocemente quale dei nostri trasportatori è disposto a fare la tratta al prezzo più basso. Sulla differenza tra il cuneo e il prezzo che lei è riuscito ad ottenere le spetta una provvigione del 2,5% fino a un abbassamento del 25%, una provvigione del 5% fino al 50% e addirittura del 10% se il cuneo supera il cinquanta. Sembra difficile ma è molto semplice: quel viaggio dovrebbe costare 10.000 euro ma lei riesce a venderlo a un camionista a 5000 e con una telefonata si è guadagnato 500 euro puliti. Mica male, eh?»
«Eh.»
«Già.»
«Ma perché slancio?»
«Il nome? Perché questo nome?»
«Sì. Una curiosità.»
«Mi sembra facile. Iniettiamo soldi nel mondo del lavoro, creiamo economia, spostiamo merci, accontentiamo clienti e lavoratori. Se al camionista non arrivasse quella telefonata avrebbe il camion fermo in giardino per farci giocare il figlioletto con il clacson e la leva del cambio. Il suo lavoro è tenere tutte queste persone in circolo, con tutti i loro talenti.»
Qui sorrise con trentadue canini. Era evidente che aveva trovato una formula diversa dalla consuetudine intirizzente e ne era entusiasta. L’avrebbe raccontata ai colleghi, agli amici del golf e alla mogliettina simulatamente fiera che l’avrebbe ascoltato mentre sceglieva il sushi. Da noi, in quegli anni lì, il sushi era un marziano con il salotto aperto solo agli eletti.
«Ma lei capisce, signor Gatti, che la responsabilità del ruolo e il prestigio dell’azienda ci impone di scegliere persone con i giusti talenti.»
Daje, con i talenti. Mi venne in mente zio Paperone. Con i sacchi di talenti.
«Per questo ho bisogno di sapere tutto di lei e di protocollo le farò anche delle domande personali. Dobbiamo avere la certezza di affidare il nostro slancio a persone che insieme a noi vogliano cambiare il mondo, aperte a sfide nuove e capaci di interagire con il futuro dandogli del tu.»
«Ovvio.»
«Mi dica Gatti, perché è interessato ad entrare nel mondo della logistica e della grande distribuzione?»
«Perché amo la mobilità. Ecco.»
«Cioè?»
«Credo che il commercio sia la più alta realizzazione delle capacità umane e essere partecipe di un’organizzazione che riesce a dare del tu a tutti i continenti sia una bella sfida.»
«Perfetto. Molto bravo. Ha già capito il nostro spirito. Siamo esploratori, noi. Ha intenzione di farsi una famiglia?»
«Certamente. Pur rispettando la mia autonomia.»
«Appunto. Perché qui non si può fermare il mondo per un anniversario, lei mi capisce. Questo non è un lavoro…»
«È una missione.»
«Una missione. Esattamente. Vuole avere figli?»
«Per ora no. Una famiglia mi basterebbe. Vorrei prima concentrarmi sulla realizzazione personale.»
«È molto maturo per essere un musicista della domenica, Gatti. Anche se ha letto il greco e latino.»
«La ringrazio.»
«Qui c’è gente che si è presentata in braghe di tela come lei e ora si porta a casa dodici, quindici, diciotto milioni al mese. Ma bisogna crederci, essere all’altezza dei propri sogni, come dice il nostro capo tutti gli anni alla cena di natale. Mi dica Gatti, ma lei è all’altezza dei suoi sogni?»
«Oh certo.»
«Perché qui ha il dovere di sognare. Non so se mi capisce. Questo non è un lavoro, come dirle, è l’affiliazione a un sogno. Qui non ci sono orari e domeniche perché i nostri collaboratori hanno bisogno di venire in ufficio, hanno bisogno di ribassare il cuneo e sentono la necessità di dimostrare al mondo che è possibile spostare un bancale di mille chilometri a metà del prezzo che la società ci vorrebbe imporre. È un fuoco che senti dentro».
«Capisco bene.»
«Capisce, va bene, ma lei ce l’ha il fuoco? Me lo faccia vedere! Ce l’ha il fuoco dentro?»
Sai che forse ci credono davvero questi a quello che dicono? Francesco una volta mi disse che sì, che secondo lui succede che a forza di riempire di polpettone il tacchino qualche tacchino si convince di essere polpettone. Lui aveva suo padre che vendeva porte blindate, le porte blindate più blindate tra le porte blindate, e quando a casa di Francesco gli zingari gli sono entrati in casa per rubargli pochi spicci, le mozzarelle e cagargli sul divano anche quella volta lì suo papà disse che dovevano essere una banda di professionisti, rapinatori da musei e ministeri, se erano riusciti a debellare la sua porta blindata.
«Io ce l’ho il fuoco. Me lo sento che brucia.»
«Perché questo è il punto di partenza essenziale. Senza quello io e lei non facciamo neanche questo appuntamento, altrimenti. Perché è lei che vuole venire con noi. Ma come lei ce ne sono migliaia. E bisogna scegliere bene chi ci prendiamo in famiglia.»
«Certamente. La sua è una bella responsabilità, mi immagino.»
«Lo può dire forte, Gatti! Lo può scrivere mille volte sulla lavagna! Ma lei cosa vuole fare da grande?»
«Essere in squadra per una grande impresa.»
«Molto bene.»
«Grazie.»
«Guardi questo test, guardi qui. Deve mettere una croce. È alla guida di un treno e c’è una biforcazione. Se continua sulla sua direzione troverà sei persone sui binari e inevitabilmente sarò costretto a ucciderli però può azionare lo scambio e decidere di prendere l’altra biforcazione dove sui binari c’è un uomo solo. Da che parte va, lei, Gatti?»
«Non è facile.»
«Non c’è tempo Gatti! Non ha troppo tempo! Non si può spegnere lo slancio!»
«Ne uccido uno solo, forse.»
«Ma è colpa sua, così!»
«Beh, non credo che se uccido gli altri sei mi facciano patrono del paese…»
«Sa qual è la risposta giusta?»
«No.»
«La risposta giusta anche se non c’è il quadretto della risposta giusta?»
«Mi dica.»
«La strada più breve. La più breve è la risposta giusta.»
«Ah, ok.»
«Ha qualche domanda?»
«Niente in particolare. Volevo chiedere, nel caso in cui io possa andare bene, l’inquadramento. Lo stipendio.»
«Le do un consiglio Gatti. Al di là di questo nostro incontro e che poi venga o no a lavorare con noi. Le do un consiglio. Parlare di soldi a un colloquio di lavoro è terribilmente inelegante».
«Sì, questo lo so».
«Però ci è ricascato. Pensi lei se io dovessi essere così rozzo da raccontarle che dispendio di soldi, tempo e energie è per noi fornirle una postazione, occuparci del telefono, le cuffie, il computer, i programmi, il suo armadietto, il badge, la mensa. Pensi quanto mi costa impiegare qualche collega esperto, di quelli che hanno lo slancio dentro, per spiegarle come funziona. Pensi a uno della nostra squadra che piuttosto che iniettare economia deve istruire uno appena arrivato. Gliene ho parlato? Forse mi ha sentito che le faccio pesare il fatto che qui da noi sapere sviolinare il pianoforte conta come il due di picche quando briscola è bastoni? È cambiato il mondo per voi giovani. Io vi invidio. Avete di fronte un futuro aperto a tutte le possibilità: la domanda che dovete fare non è «quanto mi pagate» ma «quanto valgo, io?». Io non le do niente, io non voglio essere come una volta il padrone della sua vita, io sono qui perché lei mi dica quanto guadagnerà. Sono io che glielo chiedo. Quanto guadagnerà Gatti?»
«C’è un rimborso spese?»
«Sono duecentocinquantamila lire di anticipo di provvigioni per i primi sei mesi. Volendo vedere c’è anche un milione di computer sulla sua scrivania, ottocentomila lire di media di bolletta telefonica per ogni collaboratore, la cancelleria e soprattuto questa azienda che vede, che il proprietario ha voluto bella e accogliente più di casa sua.»
«Ho capito. Mi è tutto chiaro.»
«Lei mi piace Gatti. Glielo confesso perché mi piace. Magari mi sbaglio anche se in tutta la carriera non mi sono sbagliato mai ma sento il suo fuoco. Mi prendo il rischio, via: se vuole domani ci vediamo alle 7 e iniziamo. Non lo dica a nessuno che l’ho deciso così su due piedi ma ogni tanto voglio fidarmi del mio istinto. Forse si è perso un po’ con la musica e la scuola ma le posso raccontare di un collega che non sapeva nemmeno parlare in italiano e ora è un caporeparto con la Golf aziendale e uno stipendio da favola. Non le dico il nome solo perché sarebbe inelegante ma lei ha quella luce negli occhi. Se lo prende qui da noi il diploma, si laurea in slancio. Eh?”
«Domani però non posso. Domani.»
«E perché?»
«Ho avuto un lutto.»
«Mi dispiace tanto.»
«Però vi chiamo. Vi chiamo io.»
«Va bene Gatti. Va bene. L’aspettiamo. Come una famiglia!»
Il mio #buongiorno lo potete leggere dal lunedì al venerdì tutte le mattine su Left – l’articolo originale di questo post è qui https://left.it/2018/05/01/il-colloquio-di-lavoro/ – e solo con qualche giorno di ritardo qui, nel mio blog.