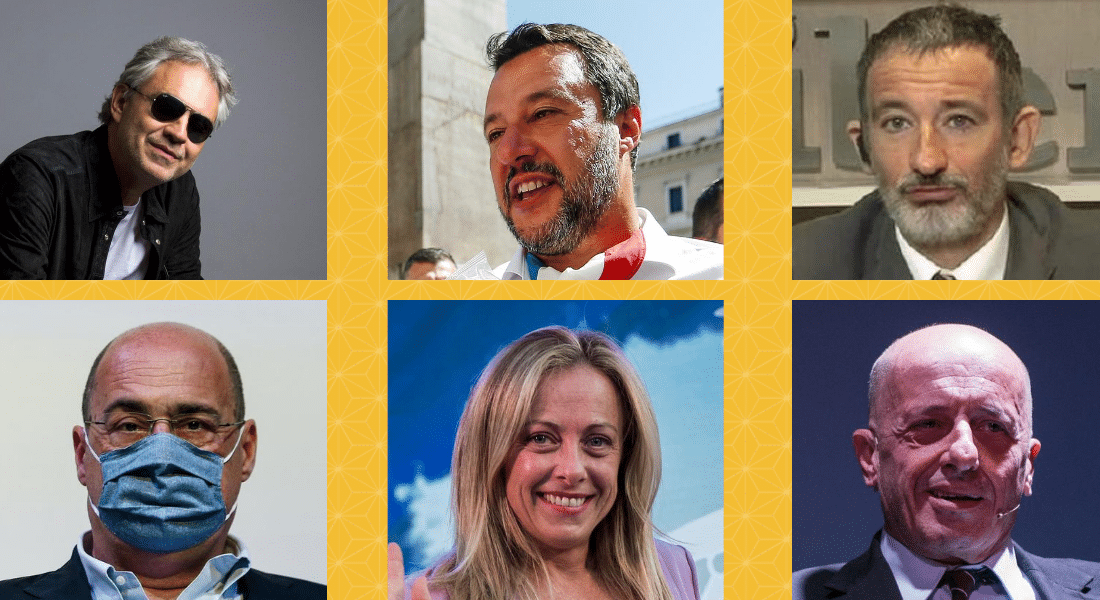(Sandro Gianni racconta la sua esperienza per Clap, qui)
A giudicare dagli annunci nei portali per la ricerca di lavoro, sembra che sul mercato esistano solo tre tipi di occupazioni disponibili: sistemista Java, dialogatore e operatore call-center. Se non conosci Java e hai zero voglia di vendere il tuo tempo per delle chiacchiere con degli sconosciuti, al telefono o dal vivo, la ricerca pare senza possibili sbocchi. Aggiungi che la percentuale di risposta ai curriculum inviati rasenta lo zero e che la laurea e/o i master di cui sei in possesso non sono particolarmente quotati nella borsa degli skills… il quadro si complica parecchio.
Perciò, quando qualcuno ha finalmente risposto alla mia “iscrizione a un’offerta di lavoro” ho provato una strana sensazione, di affetto quasi. Ho pensato di dover ricambiare, presentandomi al colloquio. Ho detto “qualcuno”, ma in realtà avrei dovuto dire “qualcosa”: un algoritmo, un dispositivo automatico di risposta alle mail, un bot del portale. Non posso saperlo, ma l’invito a comparire in un hotel nella zona di Tor Vergata è arrivato pochi millesimi di secondo dopo l’invio della mia iscrizione. Ciò esclude la mediazione umana e, dunque, una seppur minima selezione del curriculum, che avrebbe potuto equivalere a qualche decimale in più nella stima probabilistica di un’assunzione .
Il lavoro non era proprio quello dei miei sogni, ma provavo a vederci delle sfumature positive: la possibilità di viaggiare, avere un contratto decente, ricevere uno stipendio non troppo basso. Ovviamente, mi sbagliavo.
Nell’atrio dell’hotel di lusso, nella periferia sud-est di Roma, una quarantina di ragazzi e ragazze tirati a lucido, con la barba fatta, il vestito e la cravatta siedono in silenzio. Tra loro, io. Alcuni si muovono sicuri nei completi eleganti, camminano come se nulla fosse, bevono il caffé senza bisogno di sistemarsi di continuo la giacca, muovono le mani sullo smartphone senza domandarsi perché la camicia faccia capolino solo da una delle due maniche. Altri sono impacciati, si toccano insistentemente la cravatta temendo che il nodo si sciolga, cercano delle tasche in cui infilare le mani senza trovarle, provano a controllare la continua fuoriuscita della camicia dalla giacca senza alcun successo. Evidentemente, non sono abituati a conciarsi così. Tra loro, sempre io. C’è anche un ragazzo che deve aver letto male le istruzioni per l’uso: si è presentato in jeans e camicia a quadrettoni, rossi e blu. È imbarazzato, ma resta. Sembra simpatico.
In sala nessuno fiata. Quasi che taller e vestiti abbiano trasmesso per metonimìa un certo dovere di contegno, di formalità. «Dicono che l’abito non fa il monaco, ma non è vero» – argomenta il Totò ladro vestito da carabiniere, nei Due marescialli – «Io a furia di indossare indegnamente questa divisa, marescia’… mi sento un po’ carabiniere».
Ci chiamano e andiamo tutti insieme nel seminterrato dell’albergo, in una sala conferenze. Eliminata la prima decina di candidati con un test di inglese da seconda media, la selezione entra nel vivo. O meglio, nel video. Proiettano una presentazione del lavoro, divisa per sezioni: informazioni tecniche sulle diverse mansioni; procedure di inizio; questioni retributive e contrattuali; possibilità di carriera; criteri di premialità; caratteristiche dell’azienda che offre il lavoro e dell’agenzia di recruitment che assume (due cose diverse: una è Ryan; l’altra una fusione tra Crewlink e Workforce International… sì, si chiama proprio così!). In questa seconda fase, si rivolgono a noi come fossimo già assunti. L’uomo sulla cinquantina, inglese o irlandese, responsabile del reclutamento, allude più volte a quanto staremmo bene con indosso le nuove divise da hostess e steward.
Dalle immagini del video e dagli interventi del selezionatore si capisce che ci sono soprattutto tre caratteristiche importanti per fare questo lavoro: essere disponibili alla relocation immediata; parlare inglese; essere flessibili-e-sorridenti (insieme). Le immagini mostrano giovani di tutti i colori, che sembrano felici e raccontano la loro esperienza con Ryan di fronte a un bastone per i selfie. In particolare, insistono su quanto sia utile e divertente il corso di formazione per diventare personale di bordo. Si nuota, si spengono incendi, si salvano bambolotti, si incontrano persone. «You grow up like a man, not just cabin crew».
Ma è più avanti che le orecchie dei candidati si aguzzano: quando si inizia a entrare nel dettaglio del salario e dei tempi di lavoro. La retribuzione è organizzata secondo una serie di premi e possibili punizioni, un incrocio tra un videogioco e una raccolta punti del supermercato. «Your performance is continually monitored and assessed». Monitorare e valutare. Punire solo come ultima ratio. Soprattutto premiare: per far rispettare le regole, per aumentare la produttività, per migliorare le prestazioni. I like dei clienti danno diritto a delle ricompense: monetarie, ma soprattutto relazionali. Ad esempio, la penna nel taschino è indice di un certo numero di apprezzamenti. Costituisce dunque, tra i colleghi e nell’azienda, l’indicatore di uno status particolare.
Si viene pagati un po’ in base all’orario e un po’ a cottimo. Nel senso: un fisso non esiste; sono retribuite solo le ore di volo; si percepisce il 10% su ogni prodotto venduto (…adesso lo capite il perchè di tanto rumore?). Il contratto è registrato in Irlanda o UK. Si hanno delle agevolazioni sui viaggi in aereo.
Il salario mensile dovrebbe oscillare tra 900 e 1.400 euro lordi, in base al luogo di ricollocamento. «We try to keep the wages homogeneous among our workers». Bella l’uguaglianza, quando non schiaccia tutti verso il basso… penso io. Viene poi fatto cenno a un periodo annuale in cui non si lavora e non si ricevono soldi: da uno a tre mesi. Ma il selezionatore ci assicura che questa pausa non supera (quasi) mai i 30 giorni.
Fino a qui, niente di eccezionale. Ma il rapporto premi-punizioni è più complesso e configura per intero il sistema di retribuzione. Ovviamente, se i diritti diventano premi e i doveri debiti, tutto cambia. Non si parla di tredicesima e/o quattordcesima, ma di bonus, che si ricevono solo il primo anno. 300 euro il primo mese di lavoro, altrettanti il secondo, il doppio il sesto. Chi va via prima della conclusione dei primi 12 mesi, però, deve restituire questi bonus. Inoltre, la divisa (quella bella di cui sopra) costituisce un costo esternalizzato al lavoratore: il primo anno sono 30 euro al mese scalati direttamente dalla busta paga; successivamente pare si ricevano dei soldi, ma non si capisce bene per cosa, se per lavarla o non perderla. Per ultimo, il famoso corso di formazione per diventare hostess o steward si rivela qualcosa di più di un parco giochi in cui fare festini con altri esponenti multikulti della generazione Erasmus. Principalmente, si rivela un’enorme spesa. Se all’inizio era stato comunicato che, in via eccezionale, le registration fees del corso erano dimezzate a 250 euro, è alla fine che viene fuori il vero prezzo da pagare. Ci sono due modalità differenti: 2.649 euro se paghi prima dell’inizio e tutto in un colpo; 3.249 se decidi di farti scalare il costo dallo stipendio del primo anno (299 euro dal secondo al decimo mese, 250 gli ultimi due).
Si aprono le domande. Dopo alcune irrilevanti su sciocchezze burocratiche, alzo la mano. «Ci avete parlato di un massimo di ore di volo a settimana, ma mai delle ore totali di lavoro. Quante sono?», chiedo. «Voi siete pagati in base alle block hours, cioé le ore calcolate dalla chiusura delle porte prima del decollo, all’apertura dopo l’atterraggio. I tempi di preparazione dell’aereo, prima e dopo il volo, possono variare». Varieranno pure, ma di sicuro non vengono pagati, nonostante siano tempi di lavoro.
Alza la mano quello dietro di me. «Scusi la domanda, ma ho bisogno di fare dei conti. Diciamo che uno stipendio per una destinazione non troppo cara è di 1.000 euro. Ve ne devo restituire 330 al mese tra corso e divisa. Ne rimangono 670. Dovrò prendere una stanza in affitto, diciamo 300 euro. Ne rimangono 370. In più avrò bisogno di pagare un abbonamento ai mezzi per raggiungere l’aeroporto e coprire almeno le spese della casa anche nella pausa annuale in cui non si lavora. Diciamo che, se va bene, rimangono 300 euro. E non ho scalato le tasse, perché non so come si calcolano in Irlando o UK. Secondo lei, con questi soldi si può vivere?». Sbem.
Il selezionatore della società di recruitment, fino a quel momento cordiale e spiritoso, accusa il colpo. Deglutisce. Tossisce. Arrosisce. Si butta sulla fascia, prova un diversivo. «With this work you don’t get rich, but it’s in accordance with your capacity and affords your lifestyle». Alla fine, anche qui le nostre capacità valgono poco più di un pacchetto di sigarette al giorno. Chissà, invece, come ha calcolato il nostro stile di vita!
Finito il video, io e gli altri candidati usciamo e andiamo a mangiare insieme. Da come siamo vestiti, sembriamo un gruppo di giovani businessmen in carriera, lanciati alla conquista del mercato e pronti a scalare colossi finanziari. Invece siamo lì per un colloquio che, se va bene, ci farà guadagnare meno della persona che ci serve la pizza.
Comunque, i calcoli veloci del ragazzo che ha fatto la domanda dopo di me hanno sciolto l’iniziale freddezza tra i candidati. In molti hanno perso interesse per questo lavoro. Anche per questo, si scherza e si chiacchiera. Alcuni hanno appena finito la scuola superiore, altri l’università. Altri ancora hanno già diversi anni di precarietà e i capelli brizzolati. Tra loro…
Rimango fino all’intervista, per sport. Mi capita la collaboratrice del selezionatore. Legge il mio curriculum. Niente di eccezionale, però insomma… neanche da buttare. Tutti i titoli di studio con il massimo dei voti, laurea e due master, cinque lingue, numerose esperienze di lavoro materiale e immateriale, in Italia e all’estero. «Are you sure you want to do this work?», mi chiede. Bleffo: «Eeeeeh. Why not?». «Do you know people working for us?». «No». «So, what do you know about this work?». «What you told me today», rispondo. Lei arriccia il labbro inferiore e muove la testa dal basso verso l’alto e poi in senso inverso, fissandomi con gli occhi corrucciati. Ho l’impressione che stia pensando sardonicamente “devi essere proprio una volpe, tu!”.
Saluto, me ne vado. Sulla vespa faccio i conti: due caffé al bar dell’albergo = 3 euro; un pezzo di pizza e una bottiglia d’acqua = 4 e 50; giri vari alla ricerca di vestito, cravatta e scarpe e poi fino al colloquio = almeno 5 euro; stirare la camicia = 2 euro; stampare 7 fogli di curriculum dal cristiano-copto su via di Torpignattara, che sembra sapere quando non puoi dirgli di no = 2,10 euro. Barba e capelli costo zero, taglio autoprodotto in casa. Alla fine, non mi è andata nemmeno tanto male. Qualcuno è arrivato in treno da lontano, spendendo molto di più. Per l’ennesima offerta di lavoro precario e sottopagato.
Almeno una cosa l’ho capita: nella compagnia aerea, quel low che precede il cost non è riferito soltanto ai prezzi dei biglietti, ma anche al costo del lavoro.